Lo hanno rilevato in molti: era possibile ritrovare a Salisburgo l'incredibile emozione di Berlino? Era possibile che un regista potesse reggere l'intensa interpretazione di Claudio Abbado? Era possibile infine che la spazialità della Philharmonie, usata per disporre cori e solisti, e così adatta alla forma semi-scenica, si ritrovasse nel Grosses Festspielhaus di Salisburgo? Molti sono usciti delusi, lo abbiamo segnalato doverosamente. Anzi, parecchi erano arrabbiati contro Peter Stein.
Tutto questo è ingiusto: non si può provare emozioni della stessa natura in occasione di una rappresentazione scenica, e in occasione di una rappresentazione concertante - anche se semi-scenica -. E Parsifal deve essere rappresentato. Come tutte le opere di Wagner. Dobbiamo accettare le regole del Teatro wagneriano, dobbiamo accettare la presenza del regista tra la musica e noi, dobbiamo accettare le eventuali delusioni. E' il rischio del Teatro! Peter Stein non ama Wagner. Pero non ha offerto al pubblico uno spettacolo di secondo livello, anche se forse non raggiunge la perfezione del Wozzeck o anche del Boccanegra. Rinvio alla bell'analisi del nostro socio Vittorio Mascherpa che mi sembra aver colto il vero senso del Parsifal di Salisburgo, anche se non condivido certi aspetti del suo resoconto.
Ci sono due possibilità per rendere il Parsifal di Wagner:
* o si sceglie un approccio analitico e non c'è che l'imbarazzo della scelta : si può partire dell'aspetto socio-politico ( Ad esempio Götz Friedrich a Bayreuth, nel 1982, che faceva di Parsifal una specie di liberatore, che faceva esplodere le mura del Gral per aprirlo al popolo), si può limitare alla lettura mitica e fare dei personaggi dei miti lontani (Come lo faceva Wieland Wagner), oppure si può sottolineare l'origine orientale di certi aspetti della storia, e farne una cerimonia "Zen" (Bob Wilson ad Amburgo).
* oppure l'altra scelta è quella di una lettura "naïve" che riprende tutte le didascalie di Wagner e che si accontenta di raccontare la storia...
A prima vista, Peter Stein ha scelto questa via. Claudio Abbado a Berlino aveva creato una sinfonia rude, primitiva, formidabile che creava malessere e terrore, ma anche emozione infinita (l'uso delle voci bianche nel primo atto e l'effetto delle campane, il secondo atto drammaticissimo e affannoso e un terzo atto che sembrava un'interminabile marcia funebre, con un Parsifal giovanile e volonteroso e un Gurnemanz molto vicino a Pimen, nella sua semplicità e il suo ruolo di vero motore della storia (chi manda via Parsifal verso Klingsor?). Avevo sottolineato la bellezza triste dell'insieme nel senso che Baudelaire, primo ammiratore di Wagner a Parigi, intendeva:"il Bello, ardente e triste" /"Le Beau, ardent et triste". A Salisburgo invece, Parsifal è una forza tranquilla che va, un po' perso, verso il suo destino, guarda tutto senza vedere, un ingenuo come Candide che però sceglie di non coltivare il suo giardino, ma prendere a carico la responsabilità del Gral...Personaggio triste, senza espressione, di una dolcezza infinita ma che sembra assolutamente esterno a tutte le faccende, perso nel mondo degli uomini.
Altri cantanti, altra storia, altra direzione musicale ovviamente. L'aspetto "rugoso", a volte "primitivo" sembra avere lasciato spazio a qualcosa di più "elegante", le voci bianche si sentono meno sul palcoscenico di Salisburgo che nella sala della Philharmonie, e in generale tutto quello che sembrava "aspro" nella direzione viene cancellato ...e nasce un'armonia e un equilibrio appena rotto dalle campane, il cui intervento dà un nuovo colore, vagamente terribile: è chiaro che siamo in presenza di qualcosa di immenso e misterioso. A questa armonia nata fin dall'inizio del preludio a sipario chiuso, anche se il sipario lascia intravedere sangue che cola - risponde nel primo atto un paesaggio poco ridente, ma sereno. In fondo, una baia del lago verso la quale un sentiero scende. In primo piano, una foresta stilizzata. In mezzo, una pietra sulla quale si siederà Gurnemanz. Tutti gli elementi indicati da Wagner nella didascalia iniziale sono presenti con grande precisione. Anche l'uso della tela dipinta ci rinvia alle scene ottocentesche. Chiaramente si preannuncia una lettura "archeologica"...Peter Stein seguirà con fedeltà maniacale le didascalie wagneriane anche nell'orientamento: a sinistra il Castello del Gral da dove viene Amfortas, a destra il lato di Kundry, che riguarda verso l'esterno sconosciuto, in fondo il lago. Queste soluzioni semplici si accordano bene con un palcoscenico più largo che profondo, che pone sempre problemi ai registi. Come a Berlino, due giovani Cavalieri sono cantati dai ragazzi del Tölzer Knabenchor, il coro di voci bianche di Tölz: l'effetto è non solo musicale, ma anche teatrale: vediamo tutte le generazioni del Mondo del Gral e dunque nasce l'idea di una società dove i vecchi trasmettono la storia e la tradizione ai giovani, questo sarà anche più chiaro nella disposizione dei cavalieri - su tre livelli - durante la cerimonia. A vedere questo inizio di primo atto sembra che siamo in una regia di August Everding, regista tedesco oggi sparito che ha firmato parecchie regie wagneriane negli anni settanta e ottanta e che regnava al Nationaltheater di Monaco di Baviera. Un'immagine cioè della grande tradizione tedesca. Però il segno di Stein si legge nella perfetta precisione dei gesti e nella cura dei personaggi e dei movimenti, ad esempio, nella seconda parte del primo quadro, quando Gurnemanz, Kundry e Parsifal si ritrovano da soli, e che Parsifal sviene, compongono un quadro che comincia a ricordare le pietà medioevali - dove Gurnemanz (al posto di Maria) lascia Parsifal (al posto di Cristo), riposare sotto lo sguardo di Kundry. La composizione ricorda la Pietà, ma rinvia anche alla scena del Battesimo nel Terzo atto (l'acqua che Kundry porta a Parsifal nel primo atto si ritrova nel terzo atto): così si costruisce un tessuto allusivo che ci guida verso il senso: questa scena al primo atto, aldilà della carità, non ha che un senso profano: un essere stanco sviene, e viene curato. Nel terzo atto invece, la stessa scena, con gli stessi movimenti e gesti, con la stessa disposizione, acquista un senso: si tratta di un battesimo. Se seguiamo lo sguardo di Parsifal durante il primo atto, nessun gesto, nessun movimento guida verso il significato, il Mondo (del Gral) rimane chiuso ai suoi occhi, che però cercano di vedere quello che c'è dietro. Ma nemmeno Gurnemanz con tutto il suo sapere, riesce ad andare fino in fondo dei suoi dubbi. Sola Kundry, vede...ma vedendo nel buio del suo Mondo, deve dormire man mano che apre gli occhi sull'evidenza della natura di Parsifal .
Invece, la regia della seconda scena, quella del Gral, non segue le didascalie wagneriane...La regia dunque non è così "didascalica" come ha scritto la stampa...Infatti, da una parte, il cambiamento di scene non si fa a vista, come voleva Wagner, comincia a vista quando Gurnemanz pronuncia la frase famosa "Zum Raum wird hier die Zeit"/"Qua il tempo diventa spazio". Un sipario si chiude, lasciando lo spazio alla musica, che fa scena, grazie anche alle campane che per la loro presenza, danno un colore tutto particolare a questo cambiamento: dal tempo che scorre e che viene segnato dal dramma che si sviluppa davanti ai nostri occhi, si passa allo spazio musicale che ferma il tempo drammatico per ridare il posto principale allo spazio del suono: così la frase di Gurnemanz prende senso in questa regia: il tempo, compagno del dramma, lascia il posto allo spazio, compagno della musica. Ma quando il sipario si riapre sul dramma, le condizioni della scena e i presupposti dell'inizio del primo atto spariscono. Molti hanno ironizzato sull'aspetto "scandinavo" della scena...alludendo alla famosa ditta IKEA. Una volta di più, il pubblico coglie il senso senza capirlo: un regista come Peter Stein che comincia ad ambientare l'opera con delle tele dipinte di due dimensioni nello stile ottocentesco, nello stesso atto propone nella seconda parte un ambiente fatto di scene di legno costruite in tre dimensioni. Ovviamente il contrasto ha un suo significato, ovviamente l'effetto è voluto. Dal mondo assai poetico del primo atto, mondo del racconto mitico, mondo dell'evocazione, si passa ad un mondo "reale" e geometrico fatto di mobili scandinavi di legno chiaro, cioè un mondo freddo ed impersonale : le nicchie dove vengono a porsi i cavalieri ricordano le nicchie della regia di Götz Friedrich (Bayreuth 1982): sono nicchie da sepolcro: sembra tutto pronto per un seppellimento. Sembra la galleria dei Cappuccini a Palermo. La posta in gioco è la morte di una società rinchiusa in se e che non riesce più a rigenerarsi. Questo mondo ingessato Parsifal non lo capisce: vede i movimenti, vede la sofferenza di Amfortas (un eccellente Albert Dohmen) si muove , va osservare Amfortas da vicino, mentre Wagner insiste nelle didascalie sull'immobilità di Parsifal durante tutta la scena, sul suo stato di spettatore meravigliato (Parsifal bleibt aber starr und stumm, wie gänzlich entrükt, zur Seite stehen / Parsifal rimane in piedi, di lato, immobile e muto, come in estasi). Bella l' idea di Stein di far aprire il suolo come una tomba per esumare letteralmente Titurel, salma vivente, rispondendo così alle parole di Wagner (..die Stimme des alten Titurel wie aus einem Grabe heraufdringend / ..la voce del vecchio Titurel che suona come se salisse da una tomba). Molti hanno rimproverato a Stein la coppa del Gral che si illumina di rosso, cioè il lato carta pesta della regia...Come se in quasi tutte le regie di Parsifal non ci fosse il Gral illuminato di rosso nella coppa...Anche in questo caso Stein, usando una specie di iperrealismo ci invita a non crederci, dunque moltiplica i segni vagamente ridicoli che dovrebbero indurci a non crederci e a non lasciarci commuovere. Morale della favola: poteva essere una bella storia poetica (nella prima parte), ma , dice Stein ( nella seconda parte), questa storia è ridicola, profana, inutile come la filosofia a buon mercato : Parsifal sta alla filosofia come l'IKEA sta all'ebanisteria !
Il secondo atto è profondamente diverso nella sua struttura: mentre il primo atto era tutto centrato sul racconto e sull' osservazione, - unici momenti di azione, la morte del cigno e l'uscita di scena di Parsifal -, il secondo atto è essenzialmente azione, si succedono avvenimenti e avventure...Ecco perché la direzione di Claudio Abbado non è fondamentalmente diversa a Salisburgo e a Berlino, accompagna gli avvenimenti e la sua drammaticità è stricto sensu commento, mentre nel primo atto la musica è essenzialmente azione: anche se nel secondo atto siamo nel mondo magico di Klingsor, si tratta di affari essenzialmente umani: gelosia, seduzione, sesso. Il mondo del sesso, non assente nell'opera wagneriana ma spesso represso e trasformato in sublimazione (vedere Tannhäuser, vedere Vascello Fantasma, vedere anche Lohengrin ed il suo "coitus interruptus" del III atto), viene chiaramente evocato in Parsifal. Inanzittutto perché la ferita di Klingsor è castrazione - anche quella di Amfortas - cioè ferita definitiva, che non può mai essere chiusa - e che Klingsor pone così al centro del dramma la castità. Poi perché attraverso la conoscenza sessuale si avvia la conoscenza del Mondo com'è: era già il caso di Brunnhilde, unica donna "corpo e anima" del mondo di Wagner - Sieglinde e Siegmund avevano scelto l'Amore contro la Legge e vengono puniti prima di viverlo pienamente - , Brunnhilde, che si offre a Siegfried e poi viene probabilmente violentata da Siegfried/Gunther.
Parsifal entra nel Mondo di Klingsor come è entrato nel Mondo del Gral: guarda tutto senza vedere nulla, con la stessa aria vagamente assente ; di sicuro non fa differenza tra i due mondi e si lascia sedurre tranquillamente, Parsifal è letteralmente aldilà del Bene e del Male, ha una vaga idea della sofferenza, ma non delle leggi che governano il Mondo. Onnisciente invece Klingsor, mago e sapiente, che dall'alto della sua torre sorveglia tutto. Certi sono stati stupiti dall'antenna parabolica metallica che gira..La didascalia Wagneriana dice vor einem Metallspiegel sitzend / seduto davanti ad uno specchio metallico . Certo Peter Stein interpreta in chiave moderna la nozione di specchio metallico: Radar o antenna parabolica, lo strumento sottolinea la scienza di Klingsor, sapiente perché cacciato dal Gral, la battaglia che si preannuncia sarà il combattimento della scienza contro l'innocenza. Klingsor mago onnisciente deriva il suo potere dal sapere. Inoltre, il potere di Klingsor è il potere moderno per eccellenza, il potere mediatico, della comunicazione, che è il vero potere oggi. Ricordiamo che Ruth Berghaus, nella sua celebre regia di Francoforte, aveva fatto di Klingsor un personnaggio positivo - forse positivista?- mentre il male era Amfortas... Si potrebbe anche leggere Klingsor come quello che esce dal vortice mitico-religioso per nascere all'umanità...
Ma Stein non prende chiaramente posizione: il personnaggio stupefacente di Eike Wilm Schulte, grande caratterista del canto wagneriano oggi, si impone immediatamente, malgrado una voce non proprio potente. Vestito da "Eunuco" vagamente ottomano, esso in realtà regna su un mondo dei piaceri vietati come si può immaginare un harem orientale. Le donne vestite di veli bianchi ce lo suggeriscono. L'Harem come trappola per Cavallieri troppo curiosi ! Il testo di Wagner suggerisce i veli, (zartfarbigen Schleiern verhüllt / ricoperte di veli con colori dolci), e aggiunge wie soeben aus dem Schlafe ausgeschreckt, come se fossero strappate al sonno . La regia di Stein suggerisce con i suoi veli bianchi le giovani bellezze sorprese nel loro sonno. In un secondo tempo tornano vestite per il loro "lavoro" di seduttrici...Se seguiamo l'idea dell' harem visto come palazzo dei piaceri vietati - saffici ed altri, come lo sottolinea la messa in scena, -, c'è grande coerenza nella scena con le siepi basse come un labirinto che potrebbe ricordare certi giardini ottomani (l'Alhambra di Granada...): infatti, il Mondo del Gral è alla frontiera tra cristianità e mondo arabo, e Wagner sottolinea che il Mondo di Klingsor guarda verso il Sud (Klingsors Zauberschloss - am Südabgang der selben Gebirge, dem arabischen Spanien zugewandt anzunehmen - / Il castello magico di Klingsor, sul versante Sud della stessa montagna, che è supposto guardare verso la Spagna araba )... Kundry in questo mondo è non forse la "Maîtresse", come è stato detto dalla Stampa tedesca, ma una specie di Sultana Madre, che dirige le ragazze. Peter Stein rende bene il lato lascivo del giardino riempito di ragazze, ma anche il lato "decadente", "fin de siècle", "pre-raffaelita" attraverso i colori vivi, forti, che urtano un pò il nostro comune senso dell'equilibrio. In questo sottolinea il ruolo di Wagner nel mondo culturale della fine dell'ottocento, e anche la visione mistico-simbolista che pervade l'opera intera. La composizione dei gruppi, i movimenti delle ragazze, il raggruppamento finale, tutto è molto studiato per farne dei quadri dove Parsifal, personnaggio presente-assente vestito in modo banalissimo si oppone a questo mondo di colori e di freschezza personificato dalle ragazze-fiore.
La grande scena del secondo atto è stata anche molto criticata: si è notato la difficoltà a camminare in un giardino pieno di ostacoli, la difficoltà anche a sedurre in queste condizioni...Appunto, tutta la scena è costruita sulla difficoltà. Difficoltà di comunicazione tra due esseri che si incrociano senza mai guardarsi, difficoltà a camminare l'uno verso l'altro, difficoltà a trovare uno spazio comune..ed infatti, il bacio ha luogo su una siepe, cioè su un luogo limite, frontiera tra uno spazio disegnato e l'altro. Parsifal nella prima parte non può intendere alcun discorso amoroso. Non sa cos'è. L'unico discorso possibile è quello sulla madre, sull'amore materno, elemento che sappiamo determinante fin dal primo atto e l'aspetto fisico di Violeta Urmana può confermare quest'idea di una Kundry madre e protettiva - abbiamo sottolineato prima la sua posizione di "Sultana Madre" nello "Harem" di Klingsor.... Il discorso di Kundry guida Parsifal verso quell'ultimo bacio materno che diventera il primo bacio d'amore. Il cammino di Parsifal durante questo appello di Kundry lo guida verso il centro, dove il bacio sarà consumato, un percorso complicato, ma anche simbolico che guida i sentimenti, come la "Carte du Tendre" cara ai Preziosi Francesi del Seicento, guida all'arte complessa del discorso amoroso. Dopo il bacio, la situazione si rovescia, e il discorso di Kundry cade a vuoto su un Parsifal che desidera andarsene. I due percorrono il giardino senza guardarsi, senza quasi dialogare, ciascuno nel suo problema: Salvare Amfortas per uno, Salvarsi per l'altra. Nel Mondo, ci dice Stein, è non solo difficile amare, parlarsi, comunicare, ma anche semplicemente incrociarsi: i due personnaggi non comunicano più, si dilungano in lunghi, pesanti silenzi, molto tesi, si incrociano senza guardarsi: uno dei momenti più forti è quello in cui Parsifal passa dietro Kundry senza neanche guardarla. Uno cerca di uscire dal labirinto, l'altra di trattenerlo. In intrambi i casi, il labirinto è diventato una prigione. Solo la magia può snodare il nodo...
Non abbiamo visto il finale previsto probabilmente per motivi tecnici, ma anche perché questo finale era stato accolto con molti dubbi dal pubblico. Peter Stein prevedeva una visione molto "kitsch" della lancia e della croce, che di sicuro voleva distruggere il mito "cristiano"...Nella versione alla quale abbiamo assistito, la caduta del Mondo di Klingsor è molto suggestiva, con le foglie morte che cadono sul giardino, diventato tutto appassito , ma tutto l'aspetto cristiano non viene sottolineato con insistenza e la lancia è ridotta allo stato di idea...Quindi nessuna reazione del pubblico, rimasto stupefatto dalla trasformazione del Giardino e soprattutto dalla musica, che scoppia in una violenza inaudita, e che brutalmente si ferma in un silenzio che lascia lo spettatore a bocca aperta. A tal punto che non si riesce in un primo momento ad applaudire.
Il terzo atto che formalmente ricorda l'atto primo, in realtà non ne è esattamente la ripetizione: l'ambiente è cambiato completamente, il mondo del Gral non è più ridente, i personnaggi sono più vecchi, la morte è presente dappertutto. Drammaturgicamente non è esattamente neanche lo stesso: Gurnemanz non è più relatore, ma diventa attore della storia in corso. Kundry torna ma la sua presenza, forte, rimane muta. Parsifal non è più il "folle" innocente del primo atto, neanche il Wanderer indifferente del secondo atto, ma un Cavaliere, che conosce dunque l'organizzazione sociale del Mondo. La musica è essenzialmente una lunga marcia funebre - interotta dallo splendido "Incanto del Venerdì Santo / Karfreitagszauber" che apre alla luce questo mondo diventato buio. Anche la musica della trasformazione delle scene a vista (Verwandlungsmusik) è più drammatica, più terribile, e le campane più presenti .
Il sipario apre su una visione strana: delle bollicine simili a bollicine di sapone hanno sostituito sul sipario il sangue che colava dall'alto in basso nel primo atto. Sipario color d'acqua...sembra di essere in fondo del mare..Tutto questo paesaggio desolato, deserto ricorda una visione sabbiosa degli alti fondi. In fondo all'Oceano i personaggi si svegliano. Siamo in una simbolica forte che non ha più nulla a che vedere con le didascalie: Gurnemanz emerge da un tronco che potrebbe essere una conchiglia , perché sente un grido - Kundry - venuto da un mucchio di foglie secche, esattamente dalla parte opposta sul palcoscenico: al giardino rovinato di Klingsor si oppone il Mondo rovinato del Gral, in un paesaggio che sembra la terra di nessuno. Al centro dello spazio, un'anello che circonda una specie di stagno. Questo deserto segna la situazione: la storia precedente ha prodotto solo vinti che aspettano la morte, l'annegamento. Nel mondo dove vivono gli elementi non si distinguono più, acqua, terra sabbia, cielo, il mondo è come tornato alle origini..potrebbe essere il fondo del Reno del Rheingold. I personnaggi sono soli...splendida visione di Kundry e Gurnemanz andando verso il fondo mentre Parsifal sta entrando, tre personnaggi sparsi nell'immenso spazio del Palcoscenico e che vanno verso il nulla...
La scena seguente è quella del battesimo e dell'incanto del Venerdì Santo: scenicamente ci ricorda il primo atto dove sottolineavamo la simmetria; tre personnaggi: in piedi Gurnemanz, seduto Parsifal, sul suolo Kundry, che entrano nel rito del battesimo. Parsifal entra in communità, Kundry anche, ma lo sguardo che Parsifal scambia con Kundry, primo vero sguardo verso la donna, sottolinea l'evoluzione della situazione rispetto al secondo atto: Kundry ha cambiato padrone, e da schiava del Mago è diventata partecipe del Mistero, ma in un certo senso continua a subire. L'incanto del Venerdì Santo, come provocato dalla musica sublime, potrebbe essere allora l'occasione di ritrovare la scena voluta da Wagner "Freie anmutige Frühlingsgegend /Paesaggio aperto e ridente". Invece il palcoscenico si copre da una luce cruda, verde, e il cerchio che circondava lo stagno si alza. L'incanto per Stein corrisponde ad una trasformazione dello spazio, che viene delimitato come da un'aureola nella quale le ombre dei personaggi appaiono, ma che molto discretamente lascia intravedere con il gioco delle luci e delle ombre dei disegni che ricordano il giardino labirinto del secondo atto. Siamo passati dal giardino dei piaceri a quello della purezza ritrovata. Nella buca una musica pacificata, pacata, molto meno "urgente" che a Berlino, una musica del paradiso interrotta dalle campane sempre più pregnanti. La trasformazione non si fa a vista, come nel primo atto, e ritroviamo la scena di legno del primo atto, quasi intatta, perché poco usata: al bel ordinamento del primo atto risponde un ordinamento più rapido, più svelto per mettere tutto e tutti al posto giusto, più che mai l'impressione funebre delle nicchie viene rilevata dalla presenza contemporanea della bara di Titurel e della branda di Amfortas: il Gral che dovrebbe rigenerare è diventato invece portatore di morte, di rovina e di fine. La violenza della cruda visione della ferita di Amfortas riconduce all'iperrealismo del primo atto, siamo caduti nel mondo patetico degli falsi eroi, dove tutto è offerto alla vista, cadavere, ferita, sangue...L'intervento di Parsifal interrompe questo momento più drammatico che tragico; esso pone la lancia vicino al Gral, comincia la cerimonia, e tutti due lampeggiano, una piccola lampada rossa per la lancia, e la solita luce rossa del Gral...Impossibile non notare l'effetto un pò ridicolo : Parsifal torna, dovrebbe essere un climax emotivo e siamo di nuovo nella carta pesta. Il momento dovrebbe essere sublime, le luci rosse lo rendono solo spettacolo, e spettacolo poco convincente. Stein ha voluto seguendo strettamente il libretto simbolizzare il sangue che scende dalla lancia per cadere nella coppa Der deine Wunde durfte schliessen, ihm seh'ich heil'ges Brut entfliessen / La lancia che ha potuto chiudere la tua ferita, ne vedo colare un sangue santo . Ha voluto nello stesso momento distruggere ogni possibilità di adesione mistica, allontandoci anche dalla musica. Questo divario tra quel che si vede e quel che si sente disturba l'anima dello spettatore pronto come sempre ad aderire pienamente alla magia musicale, e Parsifal, per di più, non è quello che, come da Friedrich a Bayreuth, cambia il rito: Parsifal continua a celebrare il rito come si è sempre fatto, e il Gral - c'è da temere - tornerà all'immobilismo, Kundry muore, nell'ombra - era forse l'unica capace di accompagnare un eventuale cambiamento, ma nessuno la vede . Il sipario si chiude, lentamente come lo richiede il libretto, e lentamente si apre nel sipario una croce bianca, che impone il silenzio totale alla sala per parecchi secondi, e che lascia come unica immagine finale il simbolo della Cristianità, ma anche dei Cavalieri, e cioè ma di una cristianità fissata per sempre e non in movimento ne in apertura verso il Mondo. Lezione di chiusura che lascia un pò l'amaro in bocca. La regia ha davvero influenzato la nostra audizione della musica, Nietzsche trionfa.
Claudio Abbado ha sempre considerato l'Opera come una "Gesamtkunstwerk", l'opera d'arte totale, dove si devono incontrare tutti gli elementi dell'arte, e non solo la musica. Di fronte alla concezione di Peter Stein, così distanziata da un dramma wagneriano che richiede invece totale adesione e comunione, ci troviamo al centro della contraddizione: tutti hanno notato rispetto a Berlino un'altra interpretazione, un'inflessione diversa, più raffinata, più elaborata: certo dovuta alla presenza di artisti diversi. Con Waltraud Meyer, e anche con Domingo, di sicuro Claudio Abbado avrebbe fatto altre scelte musicali, come le ha fatte per Robert Gambill e Linda Watson ; il dolce Moser, potente e così musicale, ma così raffinato nel canto - anche se un pò stanco-, la musicalissima Violeta Urmana, che , lontana dalla violenza della Meyer, canta anche lei con immensa raffinatezza e umanità, hanno indotto regista e direttore a scelte diverse. L'assenza di Kurt Moll, vero sostegno della drammaturgia a Berlino, con la sua presenza semplice, robusta, imponente, e la voce più profonda, ma anche più giovanile di Tschammer imponeva un Gurnemanz leggermente diverso. A Berlino ci aveva colpito la linfa, l'energia vitale e in fondo ottimista che pervadeva l'insieme della serata. Uscivamo pieni da un nuovo vigore - effetto Gral? -. A Salisburgo vince lo stile, l'intellettualità e l'interrogazione: usciamo pieni di dubbi, di perplessità, con il sentimento di avere assistito ad uno splendido spettacolo, di una grande intelligenza, di una grande profondità che ci invita a scavare ancora più in là, ma dove due sguardi così diversi non sono riusciti a fondersi insieme / insgesamt. Ne esce un'emozione "castrata", ma un vero regalo per l'intelligenza, tutta occupata a sbrogliare la matassa di tanti segni opposti e geniali. |
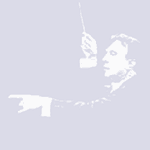 La cronaca del Wanderer
La cronaca del Wanderer